Un film di qualche anno fa, «Tutta la vita davanti», li presentava come il luogo simbolo del precariato. Sono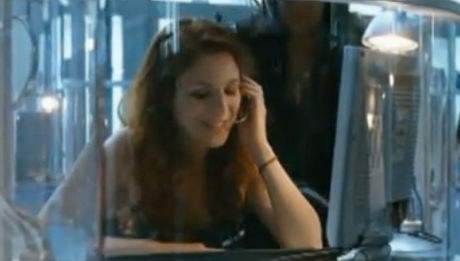 i call center, un tempo «meta lavorativa» dei giovani con qualifiche basse, oggi sempre più spesso tappa per neolaureati al primo impiego. Secondo Assocontact, associazione nazionale dei contact center, sono infatti circa 80mila gli addetti del settore, la maggior parte con un livello di scolarità alto - studi superiori o laurea - e oltre il 60% donne. La presenza di giovani alla prima occupazione è significativa. Degli 80mila lavoratori totali, più della metà - 46mila - sono dipendenti, per l’80% con un contratto a tempo indeterminato (spesso part time), più una quota di contratti a tempo determinato e di somministrazione. Gli altri 34mila sono collaboratori a progetto - che spesso però nei fatti svolgono vero e proprio lavoro subordinato. Il recente caso dei call center campani di Grottaminarda, nell’avellinese, dove sono state scoperte ben 211 posizioni lavorative irregolari, ne rappresenta l’ennesima dimostrazione.
i call center, un tempo «meta lavorativa» dei giovani con qualifiche basse, oggi sempre più spesso tappa per neolaureati al primo impiego. Secondo Assocontact, associazione nazionale dei contact center, sono infatti circa 80mila gli addetti del settore, la maggior parte con un livello di scolarità alto - studi superiori o laurea - e oltre il 60% donne. La presenza di giovani alla prima occupazione è significativa. Degli 80mila lavoratori totali, più della metà - 46mila - sono dipendenti, per l’80% con un contratto a tempo indeterminato (spesso part time), più una quota di contratti a tempo determinato e di somministrazione. Gli altri 34mila sono collaboratori a progetto - che spesso però nei fatti svolgono vero e proprio lavoro subordinato. Il recente caso dei call center campani di Grottaminarda, nell’avellinese, dove sono state scoperte ben 211 posizioni lavorative irregolari, ne rappresenta l’ennesima dimostrazione.
Nel tentativo di porre un freno all’abuso dei contratti di lavoro «flessibili», le disposizioni contenute nella riforma Fornero hanno stabilito dei limiti all’utilizzo del contratto a progetto, che riguardano anche chi lavora nei call center. Il comma 23 dell’articolo 1 stabilisce che «i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore». Ma soprattutto, poco più avanti afferma che «il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
Questo punto riguarda molto da vicino la situazione dei call center: è opportuno, però fare una distinzione tra call center inbound e outbound. Nel primo caso, gli operatori gestiscono chiamate in entrata (come accade, ad esempio, per il customer care). Anche se non è possibile fare una separazione netta, perché moltissimi di essi svolgono entrambe le attività, i call center inbound rappresentano circa il 65% del totale. I call center outbound trattano, invece, le chiamate in uscita, come nel caso del telemarketing, dove è l’operatore a contattare clienti o potenziali clienti per scopi promozionali. È chiaro che la situazione descritta dall’articolo 1, dove si parla di «compiti meramente esecutivi e ripetitivi», per i cui lavori corrispondenti non sarebbe valido il contratto a progetto, si applica alla seconda tipologia di call center: l’intenzione della riforma del lavoro è quella di ridurre il ricorso al cocopro, orientando i datori di lavoro verso forme di impiego subordinato. Per Luca D’Ambrosio (foto a sinistra), presidente di Assocontact, però, «la riforma Fornero minacciava di far sparire il contratto a progetto dalle attività outbound dei call center, non a favore dell’assunzione dei lavoratori, ma della chiusura delle attività e del loro trasferimento all’estero, a causa dell’evidente impossibilità di effettuare quelle attività con personale assunto a condizioni e con modalità accettabili». E quel «modalità» va essenzialmente letto come «costi»: perchè un contratto di tipo subordinato al datore di lavoro costa molto di più che un contratto «atipico». Quindi il timore è che, anziché stabilizzare la posizione lavorativa dei propri addetti, molte aziende chiudano i battenti per l'impossibilità di sostenere i maggiori costi di personale.
È chiaro che la situazione descritta dall’articolo 1, dove si parla di «compiti meramente esecutivi e ripetitivi», per i cui lavori corrispondenti non sarebbe valido il contratto a progetto, si applica alla seconda tipologia di call center: l’intenzione della riforma del lavoro è quella di ridurre il ricorso al cocopro, orientando i datori di lavoro verso forme di impiego subordinato. Per Luca D’Ambrosio (foto a sinistra), presidente di Assocontact, però, «la riforma Fornero minacciava di far sparire il contratto a progetto dalle attività outbound dei call center, non a favore dell’assunzione dei lavoratori, ma della chiusura delle attività e del loro trasferimento all’estero, a causa dell’evidente impossibilità di effettuare quelle attività con personale assunto a condizioni e con modalità accettabili». E quel «modalità» va essenzialmente letto come «costi»: perchè un contratto di tipo subordinato al datore di lavoro costa molto di più che un contratto «atipico». Quindi il timore è che, anziché stabilizzare la posizione lavorativa dei propri addetti, molte aziende chiudano i battenti per l'impossibilità di sostenere i maggiori costi di personale.
E in questo caso il sindacato di categoria ha una posizione simile a quella della sua controparte: secondo Giorgio Serao, segretario nazionale della Fistel Cisl, è infatti vero che «una situazione del genere comporterebbe una perdita di 30mila posti di lavoro, oltre la chiusura di alcune aziende importanti. Ed è quindi fondamentale ricercare soluzioni condivise, che possano salvaguardare l’occupazione».
La nuova normativa però in concreto cambia poco: l'articolo 24 bis del decreto sviluppo consente di mantenere contratti di collaborazione coordinata e continuativa (cococo) o a progetto per i call center outbound. Una decisione che riprende quanto già stabilito nel 2007 dall’allora ministro del Lavoro Cesare Damiano, che aveva distinto tra lavoratori dell’inbound, da considerare dipendenti a tutti gli effetti, e dell’outbound, che potevano essere anche collaboratori a progetto.
Un freno allo sfruttamento del lavoro flessibile dovrebbe essere però quantomeno la norma sulle
I cambiamenti annunciati dalla riforma si sono, insomma, conclusi con un nulla di fatto: innanzitutto la norma sancita dall’articolo 1 avrebbe riguardato solo una parte, poco più del 30%, dei nostri call center e, in ogni caso, è stata praticamente azzerata dal decreto sviluppo, che riapre la possibilità di attivare cocopro sui dipendenti di call center outbond. Con questa decisione il governo ha implicitamente ammesso che limitare i contratti a progetto - anche se in larga parte impropri - avrebbe messo in crisi o comportato la chiusura definitiva di molte aziende che gestiscono call center. Circa il 35% di esse è, inoltre, concentrata al sud, dove, in presenza di tassi di disoccupazione molto elevati, i contact center rappresentano una delle poche realtà in grado di garantire sbocchi lavorativi. Assocontact in parte tira una sospiro di sollievo: «La riforma del mercato del lavoro non riteniamo abbia dato o tolto nulla; se non fossero stati apportati i correttivi staremmo invece parlando di una situazione catastrofica», conclude D’Ambrosio. Se, però, molti posti di lavoro per il momento sono salvi, resta l’amara constatazione che ancora una volta poco o nulla è stato fatto per un settore in cui salari da fame, contratti fantasma e irregolarità sono all’ordine del giorno.
Chiara Del Priore
Per approfondire questo argomento, leggi anche:
La riforma del lavoro porterà più lavoro ai giovani? Secondo Pietro Ichino sì
Riforma del lavoro approvata: e adesso che succede?
Riforma Fornero, cosa non va secondo i sindacalisti esperti di precariato
Community