Bisogna cominciare dalle conclusioni per cogliere il senso del Rapporto sullo stato sociale 2011, incentrato su giovani, crisi e welfare e curato dall’economista Felice Roberto Pizzuti, docente di Politica economica all’università Sapienza. L’indagine, annualmente redatta con il sostegno del dipartimento di Economia e diritto della Sapienza e del Criss (Centro di ricerca interdipartimentale sullo stato sociale), fa luce su una situazione sociale al collasso. «Se gli adulti che oggi hanno maggiori responsabilità decisionali avranno la capacità d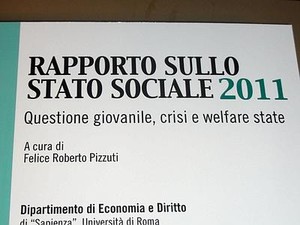 i invertire le tendenze economiche, sociali e politiche sfociate nella crisi globale, la condizione presente e futura delle attuali giovani generazioni di cittadini europei potrà avvantaggiarsene». Pizzuti ha concluso così il suo intervento alla presentazione del Rapporto presso la facoltà di Economia dell’ateneo romano, auspicando un cambiamento di rotta delle politiche governative.
i invertire le tendenze economiche, sociali e politiche sfociate nella crisi globale, la condizione presente e futura delle attuali giovani generazioni di cittadini europei potrà avvantaggiarsene». Pizzuti ha concluso così il suo intervento alla presentazione del Rapporto presso la facoltà di Economia dell’ateneo romano, auspicando un cambiamento di rotta delle politiche governative.
Il Rapporto parte da un dato: se nel 1980 le persone tra i 15 e i 29 anni erano il 22% della popolazione, adesso sono il 16%. Un crollo che rende i giovani non solo una minoranza, ma anche un elemento privo di peso sociale. In un paese in cui i padri di questa generazione hanno potuto garantire condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle vissute in prima persona, ma «se si analizzano i problemi attuali dell’entrata nel mondo del lavoro e quelli attesi sia nel periodo lavorativo sia negli anni della pensione il confronto è decisamente sfavorevole ai figli».
A colpire è soprattutto un aspetto. Si dice che questi figli «nati e cresciuti in un contesto medio di abbondanza sconosciuto ai padri, sono psicologicamente disarmati dall’erroneo convincimento che le scelte in materia di formazione e di lavoro non siano vincolate dallo stato di bisogno, ma occasioni di realizzazione individuale». Mentre la crisi economica rimette in discussione tutto, compresa la possibilità stessa di autosostentamento indipendente dalla famiglia. Alle giovani generazioni viene spesso rinfacciata la mancanza di umiltà e la scarsa voglia di mettersi in gioco accettando lavori di ogni tipo. Si finisce per colpevolizzare insomma chi, dopo aver studiato per anni puntando una meta professionale, si sia incaponito a volerla raggiungere a tutti i costi, mentre avrebbe dovuto solo imparare ad adattarsi alla realtà. Un discorso che a tratti appare un po’ ingiusto.
C’è poi una parte del Rapporto dedicata alla cosiddetta “overeducation”, ovvero l'eccesso di specializzazione in rapporto al mestiere svolto. Il tasso di occupazione medio europeo per i laureati sotto i 30 anni, riferisce l’analisi, raggiunge l’86% con una retribuzione pari al 40% in più della media. In Italia invece i laureati non ancora trentenni con un impiego sono il 60%, e guadagnano solo il 15% in più. Il gap – confermato da dati per cui ad esempio il 20% dei laureati triennali svolge un lavoro per cui la laurea non è richiesta - si spiega facendo riferimento alla struttura del sistema produttivo italiano, dove prevalgono lavori che non richiedono formazione universitaria (e di qui il basso investimento nell’istruzione). E anche quando i posti si liberano, per esempio a seguito di pensionamenti, «spesso o non vengono riassegnati o vengono coperti con contratti meno appetibili». Il vero problema, sottolinea Pizzuti, è nella «scarsa capacità del sistema produttivo di creare buona occupazione e risorse da distribuire tra tutte le generazioni».
La questione previdenziale poi è uno degli elementi più allarmanti dello studio. «Il calo della copertura pensionistica offerta dal sis tema pubblico sarà naturalmente maggiore per i non pochi lavoratori cui si prospetta la combinazione di una carriera lavorativa discontinua, lunghi periodi di contratti con basse aliquote contributive e retribuzioni salariali modeste». E il problema «manifesterà maggiormente il suo impatto economico e sociale solo tra 15-20 anni, ma è già adesso che richiede di essere affrontato con modifiche dell’assetto normativo». Pizzuti lancia come idea argine del problema l’equiparazione al 33% delle aliquote contributive dei lavoratori parasubordinati «per eliminare una differenziazione del costo del lavoro economicamente e socialmente distorsiva che incentiva rapporti di lavoro instabili e settori produttivi meno innovativi». Susanna Camusso della Cgil [nella foto] gli fa eco nel corso della tavola rotonda: «Bisogna evitare di continuare a moltiplicare le forme previdenziali. Una parte del problema è che è sui lavoratori che pesa maggiormente la contribuzione, perché spesso le imprese la evadono. Costruendo un sistema troppo povero oggi, si sta creando un debito per il paese che verrà».
tema pubblico sarà naturalmente maggiore per i non pochi lavoratori cui si prospetta la combinazione di una carriera lavorativa discontinua, lunghi periodi di contratti con basse aliquote contributive e retribuzioni salariali modeste». E il problema «manifesterà maggiormente il suo impatto economico e sociale solo tra 15-20 anni, ma è già adesso che richiede di essere affrontato con modifiche dell’assetto normativo». Pizzuti lancia come idea argine del problema l’equiparazione al 33% delle aliquote contributive dei lavoratori parasubordinati «per eliminare una differenziazione del costo del lavoro economicamente e socialmente distorsiva che incentiva rapporti di lavoro instabili e settori produttivi meno innovativi». Susanna Camusso della Cgil [nella foto] gli fa eco nel corso della tavola rotonda: «Bisogna evitare di continuare a moltiplicare le forme previdenziali. Una parte del problema è che è sui lavoratori che pesa maggiormente la contribuzione, perché spesso le imprese la evadono. Costruendo un sistema troppo povero oggi, si sta creando un debito per il paese che verrà».
Ilaria Mariotti
Per saperne di più su questo argomento leggi anche:
- «Precari. Storie di un’Italia che lavora» Il libro di Marianna Madia accende il dibattito tra Tremonti e Camusso sul welfare per gli atipici
- «Caro Gesù Bambino, ti chiediamo una pensione per i precari»: il direttore della Repubblica degli Stagisti e altri quattro giovani scrittori lanciano una proposta
Community